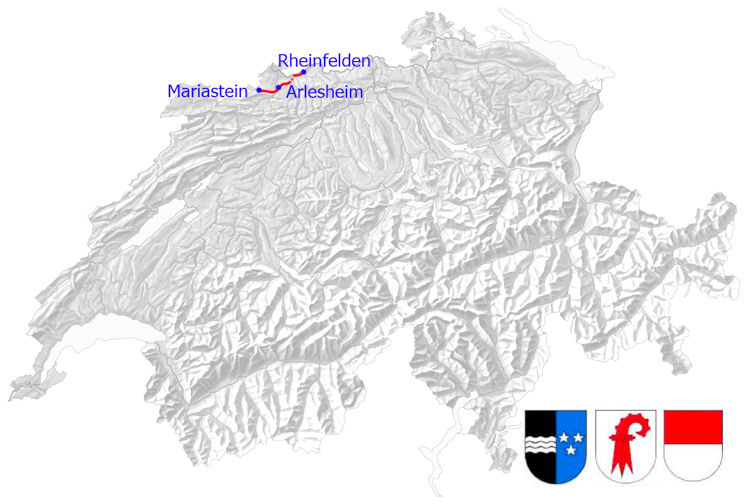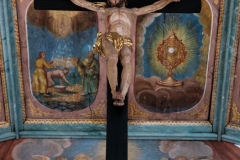CREDERE LUNGO LE SPONDE DEL LARIO
Eccoci pronti a seguire l’invito del vescovo Alain per affrontare un nuovo pellegrinaggio a piedi, il 36° organizzato da Momenti d’incontro.
Nel 2026 cammineremo lungo le sponde del lago di Como, visitando località che racchiudono importanti tesori d’arte e di fede.
Visto la vicinanza, quest’anno la partenza sarà sabato mattina 11 aprile 2026 e il ritorno il 12 aprile in tarda serata.
Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2026 e limitate a 90 persone, affrettatevi!